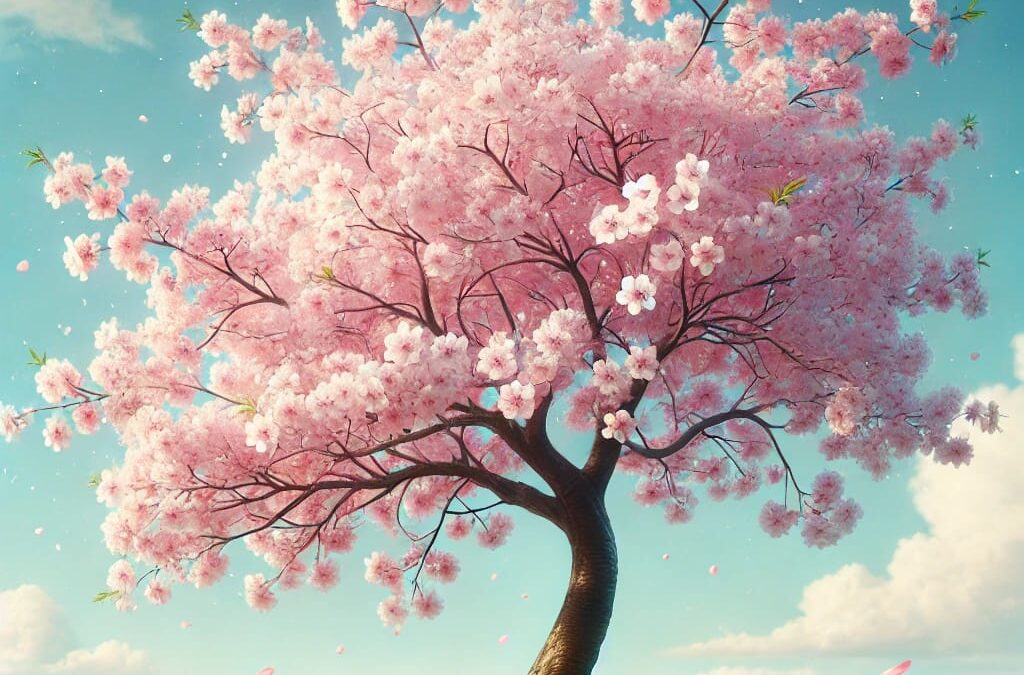Mi sono imbattuto, in questi anni, in moltissime discussioni sulla professione. In principio c’erano i forum, strumento caduto in disgrazia; la prima, efficace finestra sul mondo che potesse consentire a chiunque di confrontarsi con i colleghi di ogni parte d’Italia. Poi vennero i social, i primi gruppi, i commenti ai post, i tag, i ban. Infine, anche scrivere divenne noioso, leggere troppo faticoso, e a prendere piede furono i contenuti visuali che, ancora adesso, comandano colore.
Gli strumenti, insomma, sono cambiati e con loro la società, e non c’è che da prenderne atto, insieme alla considerazione che non tutti (io per primo) sono stati capaci o hanno avuto la volontà di tenere il passo con i cambiamenti; le domande sulla professione, di contro, sono rimaste le stesse di venti anni fa, insinuando il sospetto che non ci sia ancora stato lo scatto culturale che la nostra professione richiede, a dispetto di numerosi facilitatori che non starò qui a elencare.
Un dibattito che mi sono ritrovato a dover affrontare, molto recentemente, è stato sull’utilità delle terapie fisiche, in particolare sulla “tecar”, con dei colleghi neolaureati. L’ho trovato un po’ stucchevole inizialmente, e anche sconfortante; poi ho deciso che scrivere qualche riga mi avrebbe aiutato a ordinare i pensieri e, perché no, magari a rendermi utile per qualcuno con le idee confuse, nel senso più genuino del termine, o per qualchedun altro in cerca di aiuto per decidere che sentiero percorrere con la propria formazione e nella professione. Come è sempre stato nella mia abitudine, nello scrivere di fisioterapia abbandono ogni prudenza, perché ho sempre schifato “il giusto mezzo” di manzoniana memoria in cui si sta sicuramente comodi, ma altrettanto sicuramente fermi, se non fermissimi. Veniamo a noi. Le parole chiave per muoversi da ora in poi saranno funzionamento, business, fiducia, prescrizione.
In un corso di laurea che reputo “isola felice” nel panorama nazionale le “terapie fisiche” non sono state oggetto di studio. Dico io, non per fortuna, ma per giudizio assolutamente condivisibile di chi questo corso di laurea lo dirige. Sintetizzo adesso nella premessa fondamentale, che è funzionale al resto del ragionamento, ciò che si può leggere nella letteratura di buona qualità: le terapie fisiche non servono sostanzialmente a nulla, al punto che chiamarle terapie risulta quantomeno forzato, se non addirittura grottesco. In pochi, rarissimi casi in cui si evidenzia qualche effetto fisico, il rapporto costo – beneficio è talmente piccolo da non giustificare la spesa del macchinario, la formazione del professionista, il tempo di utilizzo, la resa finale. Qualsiasi disturbo muscolo-scheletrico si può gestire in modo adeguato senza l’ausilio di marchingegni che, al più, possono essere una stampella per chi propone la terapia, più che per chi la riceve.
Questo è lo stato dell’arte, fine della premessa.
I colleghi appena laureati e in cerca di lavoro mi hanno raccontato che “la tecar la fanno tutti gli studi professionali, anche sapendo che non serve,” perché “è per il business”.
“Mi hanno detto tutti che sanno che non funziona, ma che arrivano le prescrizioni, e quindi..”. In questo, lamentando di non avere ricevuto neanche una formazione di minima sull’argomento, che li rendesse appena autonomi nel caso si concretizzasse qualcosa con questi eventuali posti di lavoro.
Invece di trovare assurdo il comportamento da parte di colleghi ipocriti, che non hanno neanche la decenza di affermare il diritto di proporre un trattamento in cui credono, ma che anzi ammettono candidamente di non crederci neppure loro, lo hanno battezzato come “normale” perché orientato al trovare lavoro, al trovare pazienti, o ad assecondare degli ortopedici che, prescrivendola, garantiscono un flusso costante di pazienti.
Ora, i problemi qui sono enormi, disparati, e spiegano lo sconforto iniziale, almeno a me. Il primo punto è tecnico: proporre un trattamento in cui non si ha fiducia, di cui si conoscono i limiti, di cui sostanzialmente si riconosce l’inutilità. Paradossalmente sarebbe meno problematico passare le giornate a somministrare tecar (ma vale per tutte le terapie fisiche) a tutti i pazienti, in modo convinto e in piena libertà. In questo modo si diventerebbe dei fisioterapisti mediocri, probabilmente illetterati rispetto alla medicina basata sulle prove di efficacia, ma almeno si rimarrebbe onesti. L’alternativa, una volta riconosciuto il limite sostanziale di questi strumenti, è decidere altrettanto liberamente di non avvalersene; è evidente che le sfumature, qui, non sono possibili. E invece, come per la diatriba hands on/hands off, sembra che qualche minuto di tecar salvi capre e cavoli: l’ortopedico che la prescrive, il paziente che la riceve, il fisioterapista che la fattura. Un corto circuito che fa del giustificazionismo il proprio mantra, un po’ inerte, un po’ bovino, e manda un gran vaffanculo a decisioni cliniche condivise, sostenibilità, superamento del modello paternalistico della medicina riabilitativa che in ambito muscolo-scheletrico non ha nessuna ragione di esistere: salviamo vite? No – e allora si decide insieme cosa è meglio per te, mio caro paziente, in condizioni di incertezza e dovendo affrontare disturbi che per loro natura e definizione sono benigni, tendono cioè a “passare” anche da soli.
Il secondo problema è concettuale; pure ammettendo che un poco la tecar “funzioni” – e lo fa, in questo senso – ovvero riduca di un certo valore il dolore, l’infiammazione, il gonfiore; cosa abbiamo ottenuto che non avremmo potuto ottenere in mille altri modi diversi? Cosa abbiamo dato in termini di valore aggiunto? Cosa ha imparato il paziente che ha ricevuto un trattamento così passivo? Quali saranno le sue aspettative? Cosa potrà credere, se non che ha avuto bisogno di una messa a punto, come fosse dal meccanico? E chi di noi porta l’auto a riparare, se non quando è rotta? Il problema concettuale è individuare nel dolore, nell’infiammazione, nel gonfiore, degli obiettivi riabilitativi dimenticando, o peggio, non sapendo, che gli obiettivi riabilitativi riguardano prevalentemente la capacità, la funzione, il riuscire a fare cose, il poter vivere una vita di qualità anche in presenza di un sentimento sgradevole. Il problema della tecar e simili è che sono trappole che offrono ai pazienti la coccola che desiderano, ma di cui non hanno bisogno; li rendono complemento e non soggetto del trattamento, di cui noi dovremmo essere navigatori al massimo, ma non piloti.
Con la tecar prendiamo il paziente e lo mettiamo sul sedile posteriore, a fare un viaggio con esito scontato, mentre altri guidano e si godono il paesaggio. La tecar funziona, un poco? Forse sì, ma a che prezzo? L’alibi della fiducia da conquistare, utilizzando uno strumento anche se inutile, è un alibi debole, meschino. Ci sono modi eticamente irreprensibili per “conquistare” la fiducia di uno sconosciuto, clinicamente utili, facilmente applicabili. Usare uno strumento così controverso è senza dubbio il modo peggiore e sì, ha sicuramente a che fare solo con il business.
Ma non è obbligatorio essere o fare il fisioterapista muscolo-scheletrico. Esistono molti ambiti di intervento anche più interessanti, e più difficili da inquinare con pratiche borderline; il motivo è presto detto: sono ambiti che riguardano dei pazienti complessi da un lato, e proprio in virtù di questa complessità non pagano cure private ma hanno necessità del supporto del SSN. Una tecar insomma “fa qualcosa” in pazienti a cui “fa qualcosa” quasi tutto. Quanto deve pesare quindi il “business” nelle decisioni di un professionista sanitario?
Il terzo problema è il più semplice da risolvere, ed è di natura identitaria. Se l’ortopedico che abbiamo individuato per una collaborazione prescrive abitualmente la tecar, gli si dice: “guarda, amico mio, grazie per i pazienti che mi stai inviando e grazie per questa collaborazione; ti prego solo, se ti è possibile, di non prescrivere questa benedetta tecar, anche se i pazienti la chiedono, altrimenti non ne verremo mai fuori. Tu e io sappiamo che non funziona, i pazienti ancora no: se tu scrivi “fisioterapia” loro si fidano lo stesso, io non mi devo barcamenare con spiegazioni lunghissime, e facciamo un bel servizio a loro, a noi, e al sistema sanitario.” Sfido chiunque a trovare un ortopedico o qualsiasi altro specialista medico che trovi un solo motivo scientificamente valido e che non abbia interessi diretti a non assecondare questa irricevibile richiesta. In alternativa, ci sono almeno altre due soluzioni: cambiare ortopedico, e non avvalersene affatto. Se il contributo del medico specialista è prevalentemente essere un prescrittore, e le prescrizioni non vanno bene, si cambia specialista o se ne fa a meno! Decenni di lotte per la professione e grandi o piccole conquiste, maturate anche in epoca molto recente, trovano la loro ragione nell’autonomia professionale, nella conquista di un rapporto paritario con altre figure e non subordinato, in virtù del diverso contributo che ciascuna professione fornisce nel nostro sistema sanitario. A ciascuno il suo, si potrebbe dire, e il fisioterapista dovrebbe auspicabilmente non far entrare nessuno nella specificità del proprio intervento, tanto quanto non si permette di sindacare la specificità dell’intervento altrui.
Ai colleghi che non hanno ricevuto formazione sulle terapie fisiche, vorrei dire che possono considerarsi più che fortunati, e che hanno un’occasione unica per posizionarsi da subito dove sanno di poter stare, e di abbandonare prima di farlo nascere il cordone ombelicale con un prescrittore che li incateni a una macchina. A tutti gli altri, che decidono deliberatamente di stare lì, avvinghiati a un manipolo, vanno i miei pensieri più affettuosi.
Saad Youssef